
di Danilo D’ Angelo
È buffo come si facciano certi incontri. Molti lo chiamano caso o coincidenza; sta di fatto che avvengono. La maggior parte delle volte sono come scintille: nascono, brillano nella notte e si consumano immediatamente. Ma non è la loro durata che conta quanto la loro intensità e il loro contributo alla nostra evoluzione. È così che incontrai Tommaso, frate francescano di origini indiane.
Ero in Ladakh, questo il nome che prende l’altopiano del Tibet nel suo varcare il confine con l’India. Il viaggio per arrivarci meriterebbe un libro intero, ma cercherò di essere il più sintetico possibile. Era la fine di ottobre e il passo che da Manali permette il transito alle carovane che vogliono raggiungere il Ladakh era già chiuso per neve. Quindi niente autobus statale, ma solo mezzi privati che a loro rischio si avventuravano per il tragitto. Noleggiammo così una jeep con relativo autista e, io e mia moglie, partimmo alle cinque del mattino, quando il sole doveva ancora sorgere, per percorrere i 428 chilometri di strada in poco più di quindici ore.
Un momento però: il concetto di strada in questo caso è alquanto fuorviante. Stiamo parlando di una mulattiera sterrata della larghezza di non più di quattro metri ricavata scavando i pendii delle montagne himalayane, assolutamente priva di protezioni sul lato a valle, ma sarebbe più corretto definirlo il “lato a burrone” e piena di buche. Con un evidente senso dell’umorismo la chiamano “Leh-Manali Highway”, autostrada.
Altra premessa: faceva così freddo che i finestrini erano rivestiti da una spessa lastra di ghiaccio, non all’esterno della vettura, ma all’interno.
L’autista si ostinava a procedere proprio a filo del burrone che, guarda caso, era dal lato dove ero seduto io; dal finestrino continuavo a guardare a centinaia di metri sotto di me dove, assieme ai fiumi e ai laghi di un colore indescrivibile, si susseguivano carcasse di camion e autobus. Quando gli chiesi perché non stesse più verso il lato a monte mi rispose che lì la strada era piena di buche. Gli dissi se voleva dare un’occhiata all’enorme “buco” dalla mia parte che non perdevo di vista dall’inizio del viaggio. Fu allora che mi ricordai dell’altro incontro casuale che ebbi con Alex, davanti al Consolato indiano di Milano, qualche mese prima.
Fino a qualche anno fa per ottenere il visto indiano si doveva fare una lunga coda che dall’interno dell’edificio si snodava lungo la strada per diverse decine di metri. Si passavano così piacevoli giornate a colloquiare con il vicino di fila. Quella volta, mentre ero in coda con Cristina, mi si piazzò davanti un uomo dai bei lineamenti e dal fisico atletico, con un paio di occhiali da sole, che mi sorrise. Quando si levò gli occhiali riconobbi Alex, un mio vecchio compagno di liceo, prima modello e poi collaboratore di uno degli stilisti più famosi al mondo.
Casualmente, anche se le nostre vite dopo il liceo si sono allontanate, anche lui da anni frequentava l’India e, anzi, un’indiana se l’era anche sposata. Gli raccontai del viaggio che ci apprestavamo ad intraprendere e lui mi disse che aveva già percorso quel tragitto. Aveva chiesto un passaggio a un camion e, dopo qualche chilometro, si trovarono la strada sbarrata da una frana che si muoveva lentamente verso il nulla là sotto. L’autista dichiarò che avrebbe provato a passare e Alex scese dal camion. Procedendo traballante sulla frana in movimento il camion andava lentamente, ma inesorabilmente, verso il vuoto. A quel punto l’autista saltò giù dal mezzo che continuò la sua discesa verso l’abisso. Da quel momento Alex continuò la sua strada verso Leh a piedi.
È molto lesta la mente a presentarci sempre le condizioni peggiori. La paura è una componente molto forte e spesso presente della nostra vita, anche se in modo latente. È utile quando si stanno affrontando situazioni limite, fa in modo di arginare la nostra incoscienza. Molti alpinisti, per esempio, dicono d’aver paura in certe situazioni, che la paura è una loro compagna e amica che li aiuta a non prendere decisioni avventate.
A sentire le storie di alpinisti straordinari come Messner e Bonatti ci si potrà stupire nel sapere che alcune volte sono tornati indietro per la paura che provavano davanti a certe pareti estreme. Ma ancora più straordinario è che hanno sempre ammesso di essere scappati da loro stessi, non dalla montagna. Sono scappati perché si sentivano inadeguati in quel momento, non pronti.
Questo è in accordo con quanto espresso da Krishnamurti sulla paura: la paura nasce quando si evita la realtà, quando c’è una fuga; allora la stessa fuga è paura. Non siamo mai pronti a morire, perché questa è la fonte di molte, se non di tutte, le nostre paure. L’unica soluzione è accettarla, non tentare di contrastarla né tantomeno di fuggirla.
Ancor più quando l’esito non dipende da noi; per esempio, quando prendo un aereo mi concedo di avere paura fin quando non sono salito su di esso, ma una volta seduto al mio posto io non posso fare più nulla. Per cui perché avere paura? Se ho davvero paura non salgo sull’aereo, ma una volta sopra non ha senso avere paura. Stessa cosa se sono su di un’auto guidata da qualcun altro: o non ci salgo o, una volta sopra, basta avere paura. Non credete che sia stupido e inutile preoccuparsi per qualcosa che non dipende da noi? Giusto? Quindi…
Dopo circa sette ore di puro terrore – alternato a spettacoli unici di montagne di svariati colori dal rosso al blu, dal verde al giallo, ai cui piedi si ammucchiavano pietraie formate dall’azione del tempo su quelle alte e variopinte pareti, fiumi e laghi color verde acqua intensissimo, valli pietrificate contornate da cime di seimila metri immerse nel silenzio assoluto – dopo circa sette ore di queste meraviglie arrivammo ad una tenda, più precisamente una yurta, la tenda tipica dei nomadi mongoli, che nella loro lingua significa casa. Lì ci fermammo a bere un chai, contemplando il tutto in silenzio. C’era solo il vento.
Il lento e insicuro procedere del nostro mezzo si interrompeva quando incontravamo un’altra jeep o un camion che procedevano nella direzione opposta. Come si riuscisse a passare con una strada così stretta credo rientri nella sfera dell’imponderabile o quantomeno, fosse segno di una sorte favorevole.
Arrivammo al passo verso metà pomeriggio e non dimenticherò mai il cielo blu cobalto, le cime innevate, il cumulo di pietra che sosteneva il palo a cui erano legate le lung-ta, le variopinte bandierine di preghiera tipiche del buddismo tibetano. Ma soprattutto non scorderò mail la scritta sul cartello retto da quel palo: “Taglang La pass – elevation 5.359 m”, esattamente 550 metri più in alto della cima del Monte Bianco!
Fu dopo aver “scollinato”, mentre scendevamo per raggiungere la quota di 3.524 metri dove è situata Leh lungo le rive del fiume Indo, che cominciò a scoppiarmi la testa: il male d’altitudine si era concentrato attorno al mio cranio. Mi sembrava di avere una sottilissima, dolorosissima aureola che si stringeva sempre di più attorno alla mia testa: dolore che mi abbandonò solo il giorno dopo, arrivati a Leh, quando fui svegliato dal canto del muezzin. Beh, questa sì che fu una sorpresa.
A volte l’essere ignorante porta con sé degli aspetti interessanti, come fu per me in quel caso. A Leh, capitale dello Stato indiano Jammu e Kashmir, ex capitale del Regno del Ladakh, sede del Leh Palace, costruito nello stesso stile del Potala di Lhasa in Tibet, non mi sarei mai aspettato di essere svegliato dal canto di un muezzin. Scoprii, invece, che proprio al centro della città sorge la moschea Jama Masjid, eretta nel 1666, la più grande di tutto il Ladakh. È meraviglioso come in India coesistano credenze religiose in modo assolutamente pacifico.
A parte pochi esempi di genuino fanatismo – ma come si suol dire la madre degli stolti è sempre incinta – la maggior parte della popolazione indiana non solo è tollerante nei confronti delle altre religioni, ma ho visto con i miei occhi indù andare nelle case dei musulmani per onorare le loro festività e viceversa. Sono i politici che soffiano sul fuoco del fondamentalismo religioso, per portare acqua al proprio mulino che produce consensi elettorali.
Mi alzai e uscii vagando per le strade senza una meta precisa. Nemmeno all’epoca delle guide turistiche come la Lonely Planet e la Routard me ne sono mai servito, figuriamoci ora nell’era di internet. Il viaggio è scoperta, meraviglia, imprevisti, intoppi e soluzioni e soprattutto è lasciarsi vivere. Predeterminare tutto prima di partire, sapere già dove si alloggerà, cosa ci aspetterà, cosa andare a vedere non è viaggiare, è fare i turisti.
Il viaggio è una scuola di vita che t’insegna moltissimo, tra cui che programmare è inutile, perché la vita ti riserva sempre delle sorprese. Come diceva John Lennon “La vita è quello che succede mentre fai programmi”.
Che bello perdersi per le strade di una città mai vista! E così feci quella mattina vagando senza meta non curante della strada che facevo, gustandomi gli odori, i profumi, i colori e i suoni di un luogo sconosciuto. E che suoni, che odori, che colori! Il cielo blu cobalto che faceva da sfondo a montagne innevate, i colori sgargianti delle stoffe al mercato e delle spezie che si offrivano sui banchi.
L’Asia può essere una sovrasollecitazione per i nostri occhi di occidentali, tanto da indurre a giramenti di testa. Colori sgargianti ovunque amplificati dalla luce del sole in un cielo limpidissimo: i tuc-tuc gialli, verdi, rossi e neri, i sari delle donne di mille colori abbacinanti, le insegne dei locali sgargianti, i multicolori manifesti pubblicitari fino a poco tempo fa dipinti a mano, le miriadi di figure abbarbicate sui templi dipinte con colori primari piatti che le fanno somigliare a un delirio di Walt Disney.
Profumi dolcissimi come quello delle ghirlande di fiori di gelsomino che le donne, sedute per terra, vendono ai fedeli che li usano per la pūjā, l’atto di adorazione che noi fraintendiamo come “preghiera”; la fragranza sempre presente d’incenso, di solito di sandalo, che i negozianti accendono a mazzi per propiziarsi una buona giornata di vendite; l’odore dei vegetali in esposizione sulle bancarelle; l’effluvio delle essenze che si vendono, nonostante siano chiuse in boccettine di vetro; il puzzo delle fogne a cielo aperto e dei gas di scarico dei mille motorini, tuc-tuc, automobili, camion e autobus. Il tutto immerso nell’anarchia del traffico. Tra i suoni, poi, oltre al mantra dei clacson e alla preghiera del muezzin, il canto gutturale caratteristico dei monaci tibetani che proveniva dall’interno di un monastero. Era talmente potente da sovrastare il rumore del traffico cittadino.
Mi fermai con mia moglie a bere un chai in un baracchino sulla strada che metteva a disposizione dei propri clienti tre sgabelli di plastica. Ci accomodammo e sul terzo era seduto un indiano che quando ci sentì parlare tra di noi ci chiese “Italiani?” nella nostra lingua. Fu così che conoscemmo Tommaso, un frate francescano indiano. Altra sorpresa, non sapevo che esistessero francescani in India. Che bello essere ignoranti!

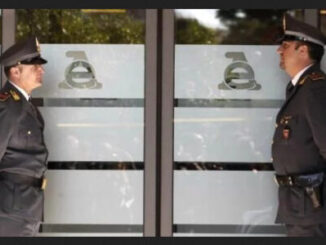


Commenta per primo