
di Marina Angelo
La vita è fatta di attimi. Ne esiste sempre uno prima e uno dopo. Ed è proprio in un attimo che tutto può cambiare. Per te o per chi ti ama. Può succedere una mattina, ad esempio, durante una corsa con un’amica. Un attimo prima, il cuore batte il ritmo della fatica e delle emozioni che corrono tra passi e parole affannate, mentre raccontano di un bacio dato qualche ora prima ad un ragazzo che pensavi non ti notasse e, invece… Un attimo prima c’è vita per la gioventù spensierata di Sarajevo. C’è un futuro da scrivere addirittura in prosa. Lo racconta Emina Gegić tra le pagine di “Nero Sensibile” ed. Albatros. Nel suo romanzo semiautobiografico, Emina incolla anche l’attimo che precede l’alba di un giorno che cambierà per sempre la sua vita. Un passo, e i cuori delle due ragazze batteranno all’’impazzata. I piedi andranno più veloci ma, non sarà più jogging. I loro occhi non saranno più rapiti dalla bellezza dell’aurora. La loro, sarà una fuga verso casa. Nei loro sguardi, si leggerà il terrore. Il metronomo del cuore, scandirà il tempo della paura. Il fiato avrà spazio per le parole. L’orrore, sarà l’attimo dopo. Il presente di quella mattina sancirà l’inizio dell’assedio a Sarajevo per quasi 4 anni. Uno dei più lunghi e sanguinosi conflitti di cui la storia bellica conserva memoria. Emina, l’attimo dopo, è tra le fortunate che sopravvive e, per lei, raccontare è un dovere. Lo deve all’attimo dopo delle famiglie di quelle 11.541 donne, uomini e bambini per cui, il momento dopo, nessun battito s’è sentito. Lo vuole per gli oltre 50mila feriti, mutilati e dilaniati dalle granate cadute a raffica sulla città. Oggi la certezza, oltre ai numeri, resta l’attimo dopo. E non sarà il silenzio.
Cosa vuol dire vivere una guerra da adolescente?
E’ sicuramente meglio che viverla da bambino. Il problema più grande è stata l’infanzia rubata a bambini che non hanno avuto modo di formarsi una personalità. Bambini privati dei loro diritti e della loro nutrizione. Cresciuti senza mai vedere una banana, minerali, calcio. Derubati di giochi e degli elementi essenziali e necessari ad una crescita sana. Io all’epoca avevo 16 anni e sono stata fortunata perché da una parte, il mio sviluppo non ha subito anche un attacco fisico. Dall’altra, in quegli anni ho vissuto una doppia guerra che, se inizialmente mi inorridiva, le granate mi hanno convinta a lasciarmi guidare dagli ormoni. Così, insieme ai miei amici, ho cercato di modificare la realtà ridendo tantissimo. Ovviamente sempre rispettando le regole. Altrimenti non ne esci viva.
Inizia così la chiacchierata con Emina Gegić. Gli occhi chiari e trasparenti che da queste prime battute si velano di ricordi mai troppo lontani nonostante il tempo e lo spazio vogliano sancirne un prima ed un poi. I sopravvissuti ad una guerra quell’”ora” la portano dentro. Nonostante tutto.
Di cosa ridevate?
Sdrammatizzare, sembra un ossimoro, ma è fondamentale. Raccontavamo un sacco di barzellette che erano diventate ormai come la sertralina (un integratore per gli stati depressivi). L’humor nero in quel periodo s’è rivelato essenziale: ci ha aiutato ad accettare la morte e a ridere di lei. Alla fine la interiorizzi come parte della vita. Ti entra nel DNA. Anche dopo, quando hanno diagnosticato il cancro a mio padre, abbiamo esorcizzato questo male come avevamo imparato in guerra. Lui mi ha raccontato una barzelletta: un uomo scopre di avere il cancro, va a comprare le sigarette e sul pacchetto la scritta dice “il fumo provoca impotenza”. Allora l’uomo dice al tabaccaio: “mi scusi ma io vorrei la scritta “il fumo provoca il cancro”. Così abbiamo riso e così abbiamo iniziato a combatterlo.
Che odore ha la guerra?
La guerra odora di polvere da sparo. E’ un odore terribile. Ti si attacca alle narici negli anni e non ti lascia. Tutte le vittime di guerra soffrono di amnesia parziale. Un problema che ho riscontrato scrivendo il libro: vivevo le sensazioni ma non riuscivo a focalizzare le immagini. Ho dovuto affrontare una lotta con il mio lato oscuro: ricostruire ricordi; affrontare, ancora una volta, le emozioni ed esprimerle non nella lingua madre ma, nella lingua padre (l’italiano ndr).
Durante gli anni dell’assedio a Sarajevo la resistenza si faceva con la cultura, la gente sfidava i cecchini e il freddo pungente per uscire dai rifugi e ritrovarsi nei teatri e nei luoghi di aggregazione. Anche tu ti salvi con l’arte dentro la quale poi, ti rifugi restando per un po’ nell’ombra.
Certe volte stare nell’ombra è una questione di comodità. Alcune professioni, come il drammaturgo, te lo permettono. Questa figura sta nella stanza verde e dà luce (verde) da mettere in scena. E’ un mestiere che ti obbliga a guardare dentro te stessa. Un po’ come questo romanzo: la luce verde di un “Nero Sensibile” con cui scrutarti. Trovarsi dentro ad una tempesta e non riuscire a guardarsi nel momento in cui accade ma poterlo fare dopo.
Cosa si nasconde dietro questo titolo?
Nero Sensibile è un messaggero che porta sempre e comunque un’accoppiata di notizie. Mai una. Mai tre. Sempre due. La seconda notizia del messaggero è che la paura può trasformarsi in una bellissima occasione
Evitando di spoilerare il libro ti chiedo chi è Emina oggi?
Un continuo upgrate. Soprattutto da quando ho iniziato a sognare in italiano e smesso di etichettarmi. E’ proprio quando smetti di chiederti “chi sei” che lo scopri. Noi siamo tante cose. Soprattutto nei momenti difficili. Io mi esprimo e basta. Sono sempre in continuo e costante sviluppo. E l’arte è la terapia di questa evoluzione, oltre che una necessità: se non scrivo, non dipingo, non canto…beh, mi rotolo come un maiale nel fango.
Sarajevo era assediata da oltre 200 carri armati e non solo. Circa 300 erano le granate che ogni giorno dilaniavano la città e i suoi abitanti. Dodicimila i soldati che stringevano la capitale in un cerchio di 62 chilometri. Cosa fa la paura?
La paura è un grande catalizzatore. Quando si presenta nella quantità giusta, è un amico perché ti dice: “attenzione, sei difronte al nemico”. Viceversa si veste da nemico quando arriva in dosi massicce (un po’ come quando prendi dosi eccessive di un medicinale). Quell’eccesso assimilato durante la guerra s’è rivelato dopo e s’è tradotto in “paura di avere paura”.
Oggi, però, sei una mamma coraggiosa. Cosa racconti a tuo figlio?
A mio figlio ho iniziato a raccontare fatti in pillole, dall’età di 4 anni. Durante un viaggio in Bosnia, attraversando la bombardata Santiceva Street di Mostar, il bambino, con il magone in gola, disse: “Quante bombe!” Fu allora che decisi che era tempo di raccontare veramente. A suo modo. Con le sue parole. Una storia che ha interiorizzato bene al punto da renderlo oggi, un bambino capace di battersi per l’uguaglianza.
In questa “Gerusalemme d’Europa” dove convivono, cattolici, ebrei, musulmani ed ortodossi non senza difficoltà, di fatto questa guerra non è mai effettivamente finita
Quello subito a Srebrenica è stato un genocidio importante. Le madri di quel periodo persero figli e mariti. E hanno chiesto giustizia fino ad oggi. Alcune di loro però, stanno morendo. Il rischio è che se loro passano, la storia viene affidata all’oblio e continueranno a convivere aggressori impuniti con famiglie innocenti senza giustizia. Quando sono arrivata in Italia, questo libro l’ho scritto per questo. Questa non è stata una guerra di religione. Questo ce lo vogliono fare credere.
Tra 20 anni, le pagine di questo libro saranno storia. Succederà allora l’evoluzione, cioè che impariamo dai nostri errori. Nel momento in cui l’essere umano impara dai propri errori non li ripete. In questo l’arte ha un impegno sociale: non è né politica, né religione. Serve a salvare, crescere, migliorare. Noi nell’arte della scrittura drammaturgica ci esercitiamo ad incrociare punti di vista per raggiungere una verità. Parola che, amo poco utilizzare perché ambigua. Io ad esempio, per molto tempo ho dovuto lavorare con il mio equilibrio psicofisico. Ero scossa dalle bombe che continuavano a rimbombarmi dentro. Ho dovuto lavorare con le mie emozioni e quando un superstite di guerra decide di diventare nuovamente il capitano delle proprie emozioni va in analisi. Io sono andata dal dott. Giovannelli. Dopo l’11 settembre le vittime hanno avuto immediatamente lo psicologo. Noi per 4 anni, non abbiamo ricevuto nemmeno una tachipirina.
Dopo questo passato importante, essere compresi è difficile. Tuo marito ti capisce?
In parte. Io ho superato la paura di depositare i miei domani. Mio marito ha più paura rispetto a me di scontrarsi col mio passato. Ma questo non mi preoccupa perché una buona dose di mistero è una buona ricetta per mantenere solida una relazione.
Quando è finita la guerra avevo un fidanzato italiano e i riflessi simili a quelli di un samurai. Un giorno eravamo al mare. Stavamo cucinando e stavano cadendo delle tazzine dal mobiletto sopra il lavandino della cucina. Io le ho prese al volo e lui mi ha guardato con gli occhi di chi mi avesse vista per la prima volta. Probabilmente ha realizzato che io, per salvarmi, avrei potevo fare di tutto: uccidere, per esempio oppure rubare. Insieme abbiamo riso, la cosa inizialmente mi ha divertita ma questo sguardo l’ho ritrovato negli occhi della gente durante il periodo della mia integrazione in Italia. E non mi faceva più ridere.
Come hai vissuto questo periodo?
E’ stato molto brutto. Dovevo combattere ancora. Non solo contro i fantasmi di un passato che è sempre presente ma, anche con il pregiudizio della gente. Per alcuni resti sempre la “ruba mariti”, “l’asciuga conti”. Non riuscivo a scontrarmi con l’empatia. E’ stata una frase, durante una seduta con Giovannelli, a farmi capire che se fossi stata in grado di trasformare il mio stato in una forma di virtù, tutto sarebbe cambiato. E così è stato. Ho iniziato a vedere mio essere straniera, e per di più sopravvissuta alla guerra, non più come un difetto ma, come una virtù.
Si può fare un parallelismo tra il coprifuoco vissuto durante la pandemia e quello vissuto da te durante la guerra? Affacciandoti alla finestra e guardando le file ai supermercati, ad esempio, hai rivissuto quel periodo d’assedio?
Quando sono arrivati i primi segnali d’allarme ne ho subito riconosciuto la gravità nonostante mio marito ed i miei amici mi prendessero in giro. Non è stato il lockdown a crearmi problemi ma, il fatto che, quando hanno preso le misure restrittive per salvaguardare la nostra salute io non ero a casa mia ma in Sardegna. Se vieni catapultata in un altro spazio, fuori dal contesto a te familiare, è più faticoso. Ed ancora una volta avevo il peso di chi arriva da un’altrove, stavolta non troppo lontano. Quando pagavo con la mia carta BPM, mi guardavano come untrice. Ma questa è un’altra storia. Il covid-19 ha creato un gergo improprio. Parlare di distanziamento sociale è stato scorretto. Ha generato paura nell’altro nonostante questa fosse la nostra salvezza. Ha forgiato una cultura impropria mentre invece, la cultura ci salvava. Ancora una volta.
Grazie alla cultura arrivi e resti in Italia da dove, non vai più via. Hai mai pensato di tornare a Sarajevo?
Un’attrice italiana, che probabilmente ha smesso di recitare, Giovanna Volpe, riuscì ad evacuare me e la mia famiglia traendoci in salvo dalla guerra. Ma non solo. Lei, che si innamorò dello spettacolo che avevo messo in scena con i miei amici, mi diede la possibilità di poterlo rappresentare anche in Italia. Ricordo che arrivai insieme a mia mamma, invece mio padre che era ricercato perché inviava informazioni per via del suo lavoro di cronista all’Italia, arrivò successivamente con un boing. Con mamma attraccammo a Bari dove ci accolse un’immensa folla. Io ero spaventatissima perché, un po’ come oggi, in guerra gli assembramenti sono vietati. Avevo 18 anni circa e ci veniva incontro un soldato con un mitra in mano chiamandoci per nome. Il cuore andava all’impazzata ma eravamo immobili. Ci aspettavamo il peggio. Ma poi ci spiegò che era venuto a prenderci per portarci dall’amico della signora Volpe. Solo allora mi accorsi di aver trattenuto il fiato e ripresi a respirare regolarmente. Da lì partimmo per Busto Arsizio, ospiti del sig. Roberto Daghini. Eravamo partiti senza niente. Non avevamo vestiti. E questa era una cosa difficile da spiegare anche ai coetanei. A Busto conobbi un compaesano, una specie di ladro gentiluomo, che mi regalò una busta piena di indumenti ma non mi informai mai della provenienza. Ricordo che all’inizio qualcuno mi regalò avevo un maglione con le pagliette che indossavo per andare a scuola d’italiano. Un giorno l’insegnante mi disse “Emina, molto bello il tuo maglione ma, sai che si indossa per la sera?”. Le risposi che lo sapevo perfettamente ma, che era l’unica cosa che avevo da mettere. Allora capii che ero io che dovevo spiegare agli altri la mia condizione e non aspettare che succedesse il contrario perché la gente non capiva davvero.
In questa Italia io oggi mi sento a casa. Per metà della mia vita ho vissuto a Sarajevo e l’altra metà sono rimasta qui. Se mi chiedessero ti senti più bosniaca o più italiana non saprei rispondere. Siamo cittadini del mondo. Gli italiani hanno salvato la mia famiglia due volte, la seconda è quando hanno fatto vincere il cancro a mio padre. A Sarajevo devo un riscatto. E l’ho fatto con il mio libro. La memoria è importante. Oggi sto avanzando un progetto insieme ad un gruppo di artisti e artigiani, O.Y . acronimo di Otely Yelo (tradotto in lingua Lakota, “Tempi difficili” più comunemente conosciuta come Sioux) perché l’arte che da sempre vive tempi difficili, resta l’ancora di salvezza nei momenti più duri. Avrei potuto scegliere di fare questo progetto a New York ad esempio. Ma ho scelto l’Italia. Glielo devo.
A quasi trent’anni da quel massacro è arrivato l’attimo dopo. Non tutti hanno avuto la possibilità di averne uno. Tutte le famiglie delle vittime, però, grazie al ricordo ed alla cultura, hanno la speranza di una giustizia e la possibilità di un domani migliore.
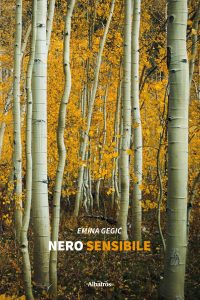





Commenta per primo