
di Francesco Carraro
Gli errori commessi dal Governo Conte, nella gestione della pandemia, sono stati numerosi. Alcuni, imperdonabili: dalla mancata predisposizione di un piano pandemico al tentativo di occultare la relativa omissione, dall’adozione di una linea “della fermezza” suicida sul piano economico-sociale (e inefficace sul piano clinico-preventivo) al sostanziale disinteresse per una filiera autoctona di produzione vaccinale. Eppure, vi è un errore ancora più grave di cui pare non essersi reso conto neppure il Governo Draghi. Uno sbaglio così evidente da spingere persino il più disincantano e il meno malizioso degli osservatori a farsi delle domande. Ci riferiamo al chiodo fisso per la dimensione spaziale dell’epidemia e alla deliberata “ignoranza” della sua dimensione anagrafica. Se ci fate caso, tutta la strategia adottata, ad oggi, contro il Covid-19 ruota attorno a un unico concetto di apparente, elementare buon senso: limitare il contatto tra le persone onde prevenire il contagio. Da qui: il lock down, il distanziamento sociale, le mascherine, il coprifuoco, la Dad, le chiusure delle attività commerciali e di quelle ludico-sportive. Infine, la suddivisione della penisola in zone colorate. Ciascuna di queste misure discende dallo stesso, maniacale imperativo: combattere la partita contro il morbo sul campo da gioco dello “spazio”. Eppure vi era, e vi è, un altro terreno su cui la sfida poteva, e può, essere se non vinta una volta per tutte, almeno combattuta con esiti assai più soddisfacenti: quello del “tempo”. Ci spieghiamo meglio. Se prendiamo uno dei più attendibili report pubblicati a valle del periodo di maggiore recrudescenza pandemica (Dataroom di Milena Gabanelli, del 15 settembre 2020) vediamo come il tasso di letalità (rapporto tra deceduti e contagiati) di una influenza normale sia dello 0,1 per cento, quello di una influenza virulenta dello 0,4 per cento e quello del Coronavirus di una percentuale variabile dall’1,15 al 3,05 per cento (a seconda del numero di infetti preso come pietra di paragone). E tuttavia, se ci focalizziamo sugli stessi dati concentrando l’attenzione a livello di fasce di età scopriamo un dettaglio decisivo: il virus è cattivissimo con gli anziani e pressoché innocuo verso i giovani. Può aiutarci a capirlo un report pubblicato dall’Istituto superiore della sanità il 10 marzo 2021: il tasso di letalità del Covid-19 è dello zero per cento fino a quarant’anni di età. Diventa dello 0,2 per cento (quindi, sempre meno di una influenza virulenta) dai quaranta ai cinquanta e tocca lo 0,6 per cento dai cinquanta ai sessanta. Il suo impressionante incremento riguarda le fasce da sessanta a settanta (2,7 per cento), da settanta a ottanta (9,4 per cento), da ottanta a novanta (19,8 per cento) e da novanta a cento (26,7 per cento). Insomma, la letalità del Covid-19 è paragonabile a quella delle influenze stagionali grossomodo fino al periodo della pensione. Ma essa diventa spietata tra le coorti più vecchie, soprattutto tra quelle “posizionate” oltre la speranza media di vita degli italiani (82 anni per gli uomini, 85 per le donne). Sono queste ultime le vittime potenziali che andavano, e vanno, massimamente tutelate. Tutti gli altri – guarda caso il target di cittadinanza comprendente la gran parte degli studenti e dei lavoratori, cioè la cosiddetta popolazione, a vario titolo, “attiva” – rischiavano, e rischiano, di morire a causa del Covid-19 né più né meno che per una banale influenza. Ne deriva una coerente conclusione: l’epidemia doveva, e dovrebbe, essere affrontata con un approccio non “topografico”, ma “anagrafico”. Quindi, ogni singola contromisura presa andrebbe, e andava, calibrata cercando di isolare, curare, proteggere le vittime preferenziali del “mostro”, consentendo a tutti gli altri di continuare a condurre una vita il più possibile normale. Pur, ovviamente, con tutte le precauzioni comunque raccomandabili in un contesto epidemico. Tradotto in prassi: le zone rosse, arancioni e gialle dovevano, e dovrebbero, contraddistinguere non già le varie regioni, ma piuttosto le varie generazioni del Paese. A voler mantenere il sistema del “semaforo” e a mero titolo di esempio, in zona rossa dovrebbero finirci gli ultra ottantenni, in zona arancione gli ultrasettantenni e in zona gialla gli ultrasessantenni. Quanto al vaccino, l’antidoto andrebbe indirizzato privilegiatamente, e prioritariamente, a queste classi di età, e a prescindere dalla professione esercitata. Per intenderci: tutti gli ultrasettantenni avrebbero il diritto di essere vaccinati prima di qualsiasi altro soggetto; pure rispetto ai giovani, o adulti, che esercitano professioni e attività particolarmente esposte. Anche perché l’ineliminabile rischio di controindicazioni di qualsiasi vaccino è tanto meno accettabile quanto più ci si sposta verso le classi di età meno vulnerabili: se ho una probabilità pari quasi a zero di morire di Covid-19, per quale ragione dovrei assumere un farmaco (assai poco sperimentato) ed espormi anche agli inevitabili, per quanto ridotti, rischi correlati? Che la strategia di cui sopra sia tutt’altro che velleitaria lo dimostra uno studio di Matteo Villa, ricercatore dell’ISPI, del 30 ottobre scorso: l’eccesso di mortalità diretta del Covid-19 scenderebbe del 74 per cento limitandosi a isolare gli ultrasettantenni. Eppure, questa via non solo non è stata percorsa, ma neppure minimamente discussa. Viene da chiedersi quante morti, e quanti fallimenti, ci saremmo risparmiati se avessimo scelto la strada di una reazione alla malattia equilibrata e “mirata” sul piano anagrafico, anziché isterica e generalizzata sul piano territoriale. Come invece è avvenuto.



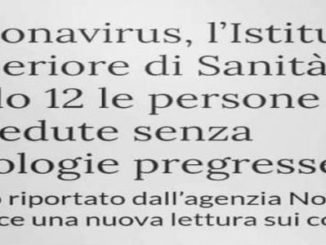
Commenta per primo